Concetto di Mole
Nel video sottostante viene spiegato il concerto di mole, concetto che spesso viene considerato difficile da assimilare:
Successivamente cliccando su QUESTO LINK si perviene in una cartella dove vi sono altri due video ( video 2 e 3) che continuando il discorso della mole, effettuano un collegamento tra la mole di una sostanza e la sua massa e l'uso che si fa di tali concetti per risolvere esercizi riguardanti le reazioni chimiche. I tre video vanno visionati nell'ordine numerico indicato. Inoltre nella cartella sono presenti due fogli di calcolo per risolvere alcuni esercizi relativi.
Successivamente cliccando su QUESTO LINK si perviene in una cartella dove vi sono altri due video ( video 2 e 3) che continuando il discorso della mole, effettuano un collegamento tra la mole di una sostanza e la sua massa e l'uso che si fa di tali concetti per risolvere esercizi riguardanti le reazioni chimiche. I tre video vanno visionati nell'ordine numerico indicato. Inoltre nella cartella sono presenti due fogli di calcolo per risolvere alcuni esercizi relativi.
***
Calcolo della quantità di reagenti e prodotti in una reazione con il metodo dei "Rapporto Molare"
Si può ingrandire il documento di sopra cliccando sulla freccia in alto a destra.
Per scaricare il documento del metodo del Rapporto Molare cliccare QUI
A seguire nel documento viene anche introdotto il metodo della "Quantità di Reazione"
Nel testo " Le basi della chimica analitica " viene esposto in modo esauriente il metodo dell "Quantità di reazione" ( da pag. 91 e seguenti
Le soluzioni: calcoli per le diluizioni
Le soluzioni: calcoli per le diluizioni
Nel video sottostante viene affrontato in modo molto semplice il problema di preparare una soluzione di un certo determinato volume e determinata concentrazione di soluto partendo da una soluzione più concentrata. A livello operativo bisognerà prelevare dalla soluzione concentrata ( soluzione 1) una certo volume di liquido (v1) e introdurlo nel recipiente dove si sta preparando la soluzione diluita. Poi in tale recipiente bisognerà aggiungere tanto solvente fino ad arrivare al volume richiesto per la soluzione più diluita ( v2)
Per fare ciò però bisogna conoscere quanto volume di soluzione concentrata si deve prelevare e trasferire nel recipiente dove si sta creando la soluzione diluita ( soluzione 2).
Per risolvere tale problema ci viene in aiuto la equazione M1 v1 = M2 v2 dove v1 è il volume di soluzione concentrata da prelevare, M1 è la concentrazione molare della soluzione concentrata da cui partire , v2 è il volume della soluzione diluita che si vuole preparare, M2 è la concentrazione della soluzione diluita che si vuole ottenere.
NB: nella equazione di sopra M1 e M2 possono essere espressi utilizzando anche altre unità, ad es. moli/L, n. Equivalenti/L, % m/V ecc.
NB: nella equazione di sopra M1 e M2 possono essere espressi utilizzando anche altre unità, ad es. moli/L, n. Equivalenti/L, % m/V ecc.
Se si vuole approfondire questo argomento cliccare QUI - nel video 2 proposto si affrontano i calcoli che bisogna eseguire per preparare le soluzioni a titolo noto, ancora altri calcoli per le diluizioni ecc.
Il resto di questa pagina è dedicata per buona parte alla trattazione degli acidi e delle basi in soluzioni acquosa ed al calcolo del ph
Per osservare nei dettagli l'animazione del meccanismo di dissociazione dell'acido cloridrico in acqua cliccare QUA
Video sull'argomento
Calcolo del ph di una soluzione acquosa di un acido forte ( HCl)
Cliccando su QUESTO LINK è possibile visionare un video che spiega il calcolo del ph di una soluzione acquosa di un acido debole ( video 2)
Per quello che concerne il calcolo del ph di soluzioni di basi forti è deboli la procedura è abbastanza simile.
Per una trattazione più approfondita e completa si può fare riferimento al video sottostante.
Per una trattazione più approfondita e completa si può fare riferimento al video sottostante.
Dissociazione di un acido debole o di una base debole in soluzione acquosa.Calcolo del ph.
Per il visionare il video di questo argomento cliccare su QUESTO LINK
IDROLISI BASICA DI UN SALE
Qui sotto vengono rappresentate le reazioni che avvengono quando un sale (formula generica ANa) contenente una base coniugata di un acido debole ( A- ) , viene sciolto in acqua. Viene anche indicata la procedura per calcolare il pH.
Per scaricare il documento cliccare QUI
In QUESTO LINK vi è un esercizio collegato all'argomento sopra esposto.
IDROLISI ACIDA DI UN SALE
Qui sotto vengono rappresentate le reazioni che avvengono quando un sale (formula generica BH+Cl ) contenente una acido coniugato di una base debole ( BH+ ) , viene sciolto in acqua. Viene anche indicata la procedura per calcolare il pH.
Per scaricare il documento cliccare QUI.
TITOLAZIONI ACIDO -BASE
Come si prepara e si usa una buretta per effettuare una titolazione
Per visionare questo video cliccare QUI.
 Titolazione di un acido forte (HCl) con una base forte (NaOH) a concentrazione nota
Titolazione di un acido forte (HCl) con una base forte (NaOH) a concentrazione notaPer questo video cliccare su Questo Link
Ma gli indicatori che si usano in chimica durante le titolazioni cosa sono? Da dove provengono?
Clicca QUI per avere una risposta.
Clicca QUI per avere una risposta.
Neutralizzazione di un acido debole con una base forte.
CURVE DI TITOLAZIONE
In questo video vengono rappresentate la curva di titolazione di un acido forte ( HCl) con una base forte ( NaOH) e la curva di titolazione di un acido debole( CH3COOH) con una base forte (NaOH).
Si ricorda che nelle curve di titolazione i valori di pH, ottenuti mediante misure potenziometriche, variano in funzione del reattivo titolante aggiunto.
Per far partire il video cliccare QUI
Standardizzazione di una soluzione di NaOH con ftalato acido di potassio
Per titolare una soluzione di NaOH spesso si usa una soluzione a titolo noto di HCl. Ma se non si dispone di una soluzione a titolo noto di HCl in alternativa si può usare lo ftalato acido di potassio.
Tale sostanza è solida ed è considerata uno standard primario ( vedere a pag. 63 e 64 del testo "Le basi della chimica analitica - Laboratorio" - quali sono i requisiti che deve avere una sostanza per essere considerata uno standard primario ).
Lo ftalato reagisce quantitativamente con gli OH- dell'idrossido di sodio formando il sale corrispondente ( completamente dissociato) e l'acqua.
In tale reazione ( vedere più sotto) il numero degli equivalenti di ftalato acido di potassio è uguale al numero di equivalenti di NaOH da dover titolare. Da tale considerazione è possibile risalire alla Normalità ( e molarita) della soluzione di NaOH.
Cliccare su QUESTO LINK per i dettagli della operazione e i calcoli.
ANALISI DELLE ACQUE POTABILI
DETERMINAZIONE COMPLESSOMETRICA DELLA DUREZZA DELL'ACQUA
In tale procedura si utilizza come agente titolante una soluzione 0,01 M di EDTA, come indicatore il NET ( nero eriocromo T).Si determina la durezza su di un campione di acqua di 100 ml.
Il risultato viene espresso in gradi francesi. (1 grado francese = 1 mg di CaCO3 in 100 ml di acqua)
Per scaricare i documenti relativi a questo argomento cliccare QUA.
Per scaricare la metodica ufficiale cliccare QUI.
fino a 4°F: molto dolci
• da 4°F a 8°F: dolci
• da 8°F a 12°F: mediamente dure
• da 12°F a 18°F: discretamente dure
• da 18°F a 30°F: dure
• oltre 30°F: molto dure.
Per visionare un video sull'argomento cliccare QUI.
Nella prima parte del video viene rappresentato il metodo descritto sopra ovvero la determinazione della durezza totale dell'acqua, nella seconda parte si descrive un metodo per determinare la concentrazione del calcio nell'acqua stessa.
Per risolvere un problema sull'argomento utilizzando un foglio elettronico di Google cliccare QUI.
A sinistra lo ione Ca++ qui indicato con M viene "chelato" da sei atomi della molecola di EDTA.
DETERMINAZIONE DEL RESIDUO FISSO A 180°
La quantità di sali disciolti in un'acqua può essere misurata determinando il suo residuo fisso a 180 gradi.
Più è alto il valore di tale residuo dopo avere fatto evaporare tutta l'acqua, più il campione di acqua è ricca di sali minerali.
Per visionare il video cliccare QUA
Per scaricare la metodica ufficiale cliccare QUI
In particolare in base al valore del residuo fisso le acque vengono classificate in:
Acque minimamente mineralizzate, con residuo fisso minore a 50mg/l, indicate per un’alimentazione neonatale, in quanto, essendo povere di sali minerali, sono altamente digeribili.
Acque oligominerali, con residuo fisso compreso tra 50 e 500 mg/l, che dissetano e garantiscono un apporto di minerali moderato. In particolare, in assenza di specifiche patologie o di particolari condizioni, l’oligominerale è tra le acque più consigliate in quanto i sali minerali vengono assunti già abbondantemente con un’alimentazione varia.
Acque medio minerali con residuo fisso tra 501 e 1500 mg/l, che sono le più indicate in condizioni in cui l’organismo ne è carente, (senilità, sport,...ecc).
Le acque ricche di minerali, consigliate in casi più specifici e che vanno assunte comunque, per periodi non troppo prolungati nel tempo e in quantità limitate.
DETERMINAZIONE DEI CLORURI NELL'ACQUA
In questo video in una facile lingua spagnola viene esposta ed eseguita la determinazione dei cloruri con il metodo di Mohr.
Per visionare il video cliccare
QUA.
Per comprendere la teoria alla base di questo metodo cliccare su
QUESTO LINK
Per scaricare la metodica ufficiale
cliccare QUI.
Per visionare un esercizio sull'argomento risolto con un foglio elettronico di Google cliccare QUI.
OSSIDABILITA' DELL'ACQUA CON IL METODO DI KUBEL
Due studenti della 4C - Tc A.S. 2015-16 mentre eseguono nei laboratori dell'IIS San Benedetto di Latina la cosiddetta determinazione della ossidabilità di un campione d'acqua.
Cliccare sulla foto per ingtrandirla.
L'ossidabilità di un'acqua consiste nel determinare quanto ossigeno servirebbe per ossidare completamente tutte le sostanze organiche ed inorganiche ossidabili presenti in un campione d'acqua da un litro.
Più è elevato tale valore più significa che l'acqua non è pura ma contiene sostanze inquinanti.
Utilizzare ossigeno gassoso per titolare tali sostanze ossidabili è alquanto scomodo in un laboratorio per cui si preferisce usare come agente titolante un analogo ossidante ovvero una soluzione acquosa di permanganato di potassio KMnO4 0,01 N che in ambiente acido ed alla temperatura di ebollizione dell'acqua ossida più o meno rapidamente tutte le sostanze ossidabili.
Dato che durante l'aggiunta del permanganato di potassio tale ossidazione delle sostanze organiche non è istantanea, per effettuare tale titolazione si usa una procedura un po' più complessa che prende il nome di "Metodo di Kubel"
Tale metodo si può scaricare da QUESTO LINK
Un'acqua per essere potabile non deve consumare una quantità di ossigeno superiore a 5 mg/litro.
Un esercizio sull'argomento risolto con i fogli elettronici di Google lo si può visionare QUI.
***
Preparazione di una soluzione 1 Molare di NaCl
***

Esercizi sulle varie grandezze delle concentrazioni
Per accedere al questo file cliccare QUI
***
IL PRINCIPIO DI LE CHATELIER
Il principio di Le Chatelier afferma: :se un sistema chimico in equilibrio viene perturbato aggiungendo o sottraendo una o più sostanze il sistema tende ad opporsi alla perturbazione prodotta.
cliccare QUI
***
Equilibri chimici, costanti di equilibrio, quoziente di reazioni, esercizi.
VIDEO
Consigliato in particolare alla la 3° E-tc - Per far partire il video cliccare su QUESTO LINK
Se si vuole questo documento in un formato più grande cliccare QUI (google drive)
ESERCIZI DI STECHIOMETRIA
Qui sotto abbiamo un elenco di esercizi di stechiometria. Ogni esercizio è mancante dei dati. Al loro posto vi sono dei puntini.
Sotto ogni esercizio, dove vi è indicata la dicitura " per risolvere il problema cliccare qui " vi è la possibilità di collegarsi ad un foglio elettronico di Google dove inserendo dei dati a piacere nelle caselle verdi, si hanno i risultati nelle caselle rosse.
Questi fogli elettronici possono essere scaricati nel formato Excel o Ods.
Sotto ogni esercizio, dove vi è indicata la dicitura " per risolvere il problema cliccare qui " vi è la possibilità di collegarsi ad un foglio elettronico di Google dove inserendo dei dati a piacere nelle caselle verdi, si hanno i risultati nelle caselle rosse.
Questi fogli elettronici possono essere scaricati nel formato Excel o Ods.
Se si vuole questo documento in un formato più grande cliccare QUI (google drive)
Se necessario fare scorrere il cursore laterale.
DAL NOSTRO INVIATO ALBERTO ANGELA



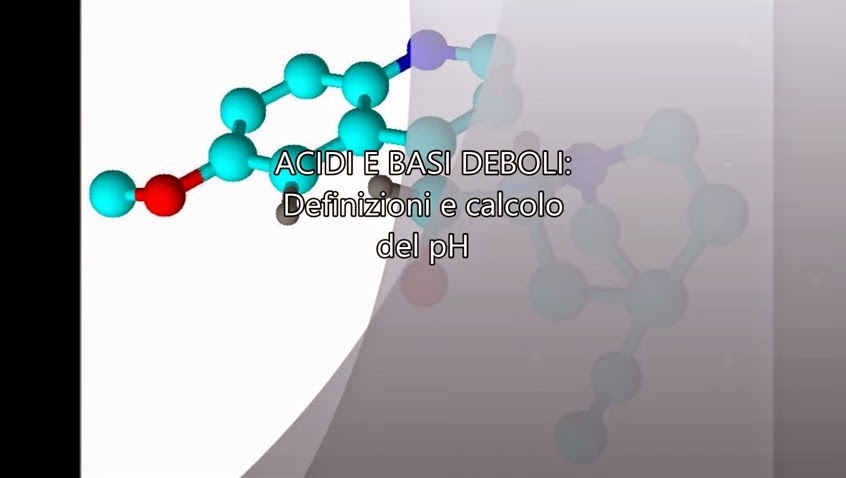










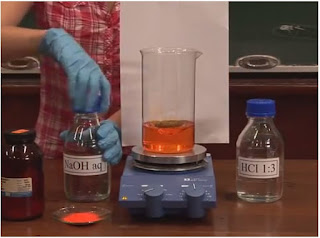


Nessun commento:
Posta un commento